|
PRIMO PIANO
|
 |
| |
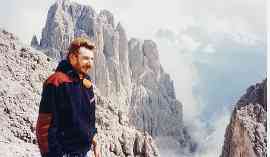
Alberto Franco sotto le cime
dolomitiche: «I primi ad amarle sono stati veneziani e triestini,
forse perché da lontano la loro bellezza abbaglia»

All'inizio di una scalata:
«Arrampicando devi pensare solo a quello: può essere una terapia»



|
Alberto Franco ha scritto un libro che racconta storia e
filosofia dei Monti Pallidi
«Scalare, che metafora»
La conquista delle Dolomiti,
palestra mondiale
«Nell'evoluzione dell'arrampicata si può leggere anche ciò
che è cambiato nel nostro mondo»
di Antonio Frigo
TREVISO. Il Monte Bianco, anzi la sua ascensione,
porta due firme, anzi tre: quella di Gabriel Paccard, quella di Jacques
Balmat e quella più occulta ma fondamentale di Horace Benedict de
Saussure. Balmat era un semplice montanaro attratto forse dalla
prospettiva del guadagno, Paccard era un medico, cioè uomo di scienza, e
portò lassù le strumentazioni per le misurazioni della montagna più alta
d'Europa. De Saussure era un aristrocratico naturalista: fu lui a ispirare
e organizzare quell'ascesa, datata 1786, offrendo anche un lauto premio a
chi l'avesse completata. Un «ràmpega» montanaro, uno scienziato curioso e
testardo, un filosofo delle conquiste alpine: l'impresa che segnò l'inizio
ufficiale dell'alpinismo è contrassegnata da tre figure che, messe
insieme, potrebbero costituire il ritratto dello scalatore completo e
illuminato, non fosse che l'aristocratico non andò lassù. Lo si evince
scorrendo le belle pagine del libro che il trevigiano (veneziano di
nascita) Alberto Franco, uomo di montagna a tuttotondo (chissà perchè
negli annali dell'alpinismo c'è tanta gente di mare) ha dato alle stampe
in questi giorni e si appresta a presentare in edicola. La scalata del
Monte Bianco, nel suo libro storico-filosofico, appassionato e sobrio come
montagna comanda, figura, naturalmente, come prototipo di alpinismo
"moderno", anche se l'occhio e la memoria di Franco cadono sulle Dolomiti,
«montagne uniche bellissime, dove si è formato il grande alpinismo
mondiale, compreso quello che poi ha dato la caccia alle cime himalaiane e
agli ottomila in tutto il mondo. Escluso Bonatti, che però "nasce"
scalatore sul cosiddetto Capriccio delle Dolomiti».
La domanda che
aleggia, sempre, tra il racconto dell'apertura di una via dolomitica e
quello dell'esordio, aborrito, dei chiodi a espansione, è «quella», la
madre di tutte le domande su ciò che è impresa e sfida all'ignoto: perché?
E ancora: visto il bollettino delle morti di alpinisti, ne vale davvero la
pena?
«Ognuno ha le proprie ragioni. Certo, è possibile individuare
alcuni precisi gruppi, ma con una serie di sfaccettature e gradazioni
interne. Pescando dai racconti dei protagonisti, ho provato a raccontarle,
io dilettante delle ascensioni, con questo libro».
Qualche esempio per
sommi capi, senza pretesa di esaustività?...
«C'entrano scienza,
valori, ideologie, perfino forme di religiosità. E non si parla solo della
tradizione italiana o europea. In Oriente, tra il settimo e l'ottavo
secolo, esisteva addirittura una scuola i cui seguaci praticavano la
scalata come una specie di catarsi. C'è anche una tradizione giapponese
che annovera oggi, dopo l'abbandono della Formula Uno, anche l'ex pilota
Katayama...».
Ma c'è in montagna anche un sacco di gente che rincorre
record: di tempi di scalata, di vie da mettere in carniere, di cime da
inanellare in una stessa stagione. Oppure un brivido, magari a sventato
scapito della vita, propria ed altrui...
«Ci sono anche questi, certo.
Consola sapere che più si arrampica e più, in genere ma non sempre,
subentra lo spirito giusto, la giusta prudenza, la voglia di armonia, il
desiderio di trovare se stessi. In montagna si muore, è vero, ma non
sempre perchè si sbaglia qualcosa. Sono morti grandi alpinisti in modo
banale: un pezzo di montagna che si stacca, quatto sassi che dall'alto ti
colpiscono in pieno. Uno dei miti, Comici, è morto perchè, per sporgersi
da una croda e guardare, sotto, gli amici, si è legato a un cordino
lasciato lì da qualcuno: il cordino s'è rotto. Sono scomparsi sotto i miei
occhi anche alcuni amici che non arrampicavano certo per voglia di record
o per sfida assurda. La dirò con le parole di Buzzati: "L'alpinismo manca
di utilità pratica? E' pericoloso? Ha in sè qualcosa di irrazionale?
D'accordo. Ma a questa stregua si ridurrebbe l'uomo a una macchina
pensante. A questa stregua non sarebbe mai nata l'aviazione, non si
tenterebbero oggi le vie degli spazi e metà della terra sarebbe ancora
inesplorata". A parte il fatto che con l'auto, senza accorgercene,
rischiamo la vita ogni giorno. E poi l'alpinismo un'utilità anche sociale,
magari non in Italia, ce l'ha».
Ovvero?
«Arrampicare richiede un
grande esercizio di concentrazione. Bisogna sempre sapere cosa si sta
facendo, pena un errore fatale. La mente si svuota da tutto il resto. Per
questo in Francia l'alpinismo viene usato come terapia di recupero per i
tossicodipendenti e per alcuni handicap. Alla fine di tanta fatica, la
sensazione è appagante, rinforza psicologicamente. In Italia qualcuno ci
dovrebbe pensare. In Francia anche tutte le scuole hanno una parete
artificiale da arrampicata...».
Ma lei farebbe arrampicare un suo
figlio a sei anni?
«Come no? Lo porterei, certo, in una palestra di
roccia. Hanno doti naturali di equilibrio e arrampicata: guardate i loro
giochi».
Perchè la gente di mare ama l'alpinismo? Perchè gli albori
dell'alpinismo italiano sono targati Trieste e Venezia?
«La prima
scuola di alpinismo nasce a Trieste, ed è un veneziano, il professor
Berti, invece, a fare la prima guida delle Alpi Orientali. Forse chi vede
le montagne da lontano ne apprezza la bellezza più di chi le ha davanti al
naso e non sa valorizzarle. Vengono da tutto il mondo, per vedere le
Dolomiti, ma noi non ce ne accorgiamo quasi. O lasciamo che vendano
brutalizzate da orde barbariche, a scopo economico. Certo, ha ragione
anche Messner quando dice che la montagna deve dare da vivere anche a chi
ci abita, ma...».
Quindi, l'ultimo momento puro e bello delle
Dolomiti...?
«L'ultimo cantore di quel modo di andare in montagna è
Buzzati, che le nostre cime le ha scalate e cantate scrivendone con rara
passione e competenza. Le ha anche disegnate e dipinte».
Scusi se
insistiamo sull'argomento, non è cattiveria, solo voglia di capire: perchè
si muore più spesso scendendo da una vetta che salendo?
«Perchè c'è un
calo di attenzione: dopo quello che sei riuscito a fare, rischi di non
metterci altrettanto puntiglio nel discendere. Sto parlando delle nostre
montagne, non dell'Himalaya, naturalmente: lì possono entrare fattori di
ossigenazione, di stanchezza. Ma le Doloniti sono diverse: in un attimo si
è sotto la parete e si va sù: niente campi intermedi, niente
ossigenazione. Sono bellissime, le nostre montagne».
Eppure gli
italiani ci sono arrivati tardi.
«Lo scrivo: le Dolomiti sono state
terra di conquista per i tedeschi, quelli con il mito di Sigfrido, cui
dedico un capitolo. Poi sono arrivati gli italiani e c'è stato, tra gli
Anni 20 e gli Anni 30, un momento di grande vivacità del nostro alpinismo:
alle conquiste delle vie e delle vette veniva dato grande risalto, il
governo premiava le "prime" con una medaglia d'oro».
Sigfrido,
Mussolini: l'arrampicata è di destra?
«No, il discorso è un altro:
l'arrampicata è un confronto con il senso del pericolo, con la coscienza
di sè. Ora il pericolo è visto in modo opposto: è motivo d'ansia, come
disturbo sociale. E pensare che siamo circondati da... normali situazioni
a rischio. Ma, fateci caso: chi non è morto in arrampicata, vive molto più
a lungo della media. E a ottant'anni c'è ancora chi arrampica».
Treviso
ha un ruolo nella storia dell'alpinismo e delle Dolomiti?
«Quando fai
il nome di Bepi Mazzotti s'inchinano non solo in Italia, ma anche
all'estero. Mazzotti è stato uno scalatore, innanzitutto: ha addirittura
messo la sua firma a una via. E poi è stato uno dei maggiori esponenti
mondiali della cultura dell'alpinismo, quella che dà un significato al
tutto. E poi c'è il nome di Cino Bocazzi, che è ancora qui a raccontare
quell'epoca. Ecco, ho cercato di leggere la storia dell'alpinismo come
metafora della storia della società e della cultura. Ci ho provato,
almeno».
Si avverte un rimpianto per i cosiddetti bei tempi andati.
Cosa manca, oggi?
«Diciamo che è stato fatto quasi tutto, da un punto
di vista delle vette da conoscere e delle pareti da attaccare. Nel libro
c'è una lunga tabella con le "firme" di ognuna di queste imprese. Ma la
montagna meriterebbe di più: perchè, con tutte le storie di alpinismo che
ci sono, a nessuno è venuto in mente, ai giorni nostri, di raccontarle con
un film? E' solo un esempio. L'arrampicata è...». E si ricomicia
daccapo...
|
![]() |
|